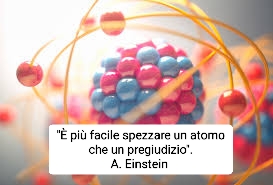Del pensiero io sono un vizio, che fa molto risparmiare; sono il pregiudizio e servo a non pensare.
Dove arrivo io infatti si blocca la conoscenza e l’immaginazione; c’è già qualche certezza che a memoria ti ha fatto la lezione.
Il nero è nero, il bianco e bianco! È molto facile ragionare, usami sempre e non ti farò mai sbagliare…
Qualcuno arriva e dice: “così è riduttivo, così non è … e con un discorso ti mostra i suoi perché. Tu fai finta di ascoltare, anche sinceramente, ma in verità di quel che dice non te ne importa niente.
Qualche volta punti il dito, specialmente se ti senti aggredito e se messo in discussione puoi alzare un polverone.
Non cerchi altro che certezze e semplificazioni, per questo vai a braccetto con gli ottusi e con i sapientoni; con quelli che sanno già tutto e non devono più imparare; parlando dicon “sono confronti” ma non fanno altro che giudicare.
Anche nelle scienze ti si incontra ti chiamano “bias” del clinico e del ricercatore, ma non è meno pregiudizio se ad esprimerlo è un dottore.
Dello stereotipo sei grande amico state molto bene insieme, la vostra unione è perfetta e specialmente ben conviene.
Perché quando già conosco tutto senza più indagare, uno schemino mi aiuta affinché ci si possa meglio orientare ed ingannare.
Tutti noi abbiamo almeno un pregiudizio nel nostro modo di pensare, con o senza dirlo in versi , ciascuno possa vederlo meglio, interrogarsi e cambiare.
Citando il noto aforisma di Einstein: “è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”, si vuole evidenziare il carattere pervasivo e resistente di qualsivoglia pregiudizio. Questo ultimo come indica il termine, è un giudizio che precede l’esperienza stessa. Basato pertanto su schemi pregressi, i quali informano il soggetto di una realtà, laddove non si dispone di dati completi, ovvero senza approfondirne la conoscenza e fondamentalmente mossi da precognizioni che tendono ad inquadrare l’ignoto, il non conosciuto, l’inesplorato, non in modo neutro e come qualcosa di autenticamente nuovo, diversamente come una realtà data, familiare, già nota. Il pregiudizio in tal senso è un meccanismo di distorsione della conoscenza ed insieme approccio ed atteggiamento acritico alla realtà. “Acritico” non vuole dire non giudicante, ma che è lontano da ogni verifica delle proprie idee, che diventano ideologiche.
Possiamo dunque già intendere una altra tipica caratteristica e funzione del pregiudizio come vera e propria distorsione cognitiva; che risiede nel suo essere un irriducibile meccanismo difensivo, capace di abbassare i livelli di ansia individuale e sociale, generati dal rapporto con una alterità tipicamente culturale, minoritaria o gruppale, tanto diversa quanto avvertita come pericolosa dalla logica maggioritaria o del gruppo di appartenenza. Questo ultimo di converso è vissuto come un organismo familiare, perché conosciuto, di cui si condividono valori, principi, norme ed a cui ci si sente o si desidera appartenere.
Il desiderio di appartenenza al gruppo spinge verso il conformismo, ovvero la tendenza ad aderire in tutto al pensiero e cultura del gruppo azzerando differenze e spinte individuali. In tal senso più è forte il senso di appartenenza, più sostenuto da una logica conformista e familistica che tende ad escludere l’ unicità del singolo ed il discostamento dalla visione del gruppo; più ogni deviazione del pensiero dalla cultura comune viene intesa come minacciosa e valutata come negativa.
Il pregiudizio come concetto, è stato ampiamente trattato dalla psicologia e dalle altre scienze umani e sociali, che ne hanno evidenziato ricadute politiche e sociali e sono orientate ad implementare interventi ad ampio spettro, tesi ad arginare il fenomeno in ogni contesto; proponendo strategie basate su visioni pluralistiche e rispettose delle diversità, queste ultime intese come risorse e valori di per sé. Il pregiudizio tuttavia viene “scoperto” e studiato in modo sistematico nel 700′ del secolo scorso, dal noto filosofo Bacone il quale, sempre in un’ accezione relativamente negativa, lo descrive da più angolature, sottolineandone caratteristiche diverse: individuali, sociali, culturali e storiche.
Le funzioni del pregiudizio nel mondo sociale, ovvero l’ “utilità”, che ne spiega e giustifica il massiccio impiego che ne viene fatto, senza peraltro ritenerlo al contempo giusto; potrebbe essere riassunta nel modo che segue.
Prima di tutto come esigenza cognitiva e di economia del pensiero; come esigenza emotiva, di difesa dall’ ansia verso l’ignoto; come “sentimento” e bisogno di difendere il proprio sistema di appartenenza e di riferimento; come meccanismo sociale volto a garantire stabilità, conformismo ed il perpetuarsi immutabile della cultura di gruppo alla quale si è legati e radicati in modo rigido ed acritico. Infine, ma non meno importante, come convinzione pregressa che determinate culture e gruppi siano pericolosi, sbagliati o moralmente inaccettabili. In tal senso il pregiudizio si completa attraverso gli stereotipi, ovvero modelli “a priori” preconcetti, che servono ad inquadrare, spiegare ed orientare la realtà in una determina direzione, già definita. Così come molte stampe possono essere ricavate da una unica matrice, lo stereotipo consente il perpetuarsi di modelli definiti, che definiscono e costruiscono la realtà.
Possiamo fare molti esempi di pregiudizi e stereotipi, secondo una accezione tipicamente negativa; ovvero attraverso cui si esercitano meccanismi di controllo, da parte di un “potere forte” a discapito di una minoranza o un “gruppo debole”, che ha minore potere di negoziazione ed è più vulnerabile a logiche di sopraffazione ed oppressione.
In tal senso citiamo le questioni: femminile; di genere; razziale; etnica; religiosa; disabilità e molte altre che evocano storie di soprusi, violenze e sopraffazione. Queste questioni ci richiedono sempre più visioni alternative di conoscenza della realtà, capaci di enfatizzare il pluralismo; puntando anche su ciò che unisce, ma senza escludere differenze, anzi valorizzandole. Incrementando l’autoefficacia, la self agency ovvero la capacità di agire ed incidere sulla realtà che si vive e sul proprio cambiamento; l’ advocacy Intesa come capacità di far valere i diritti delle minoranze e fasce deboli; e non ultimo l’empowerment come esercizio di potere inteso in una logica di non oppressione, ma di rispetto e cambiamento.